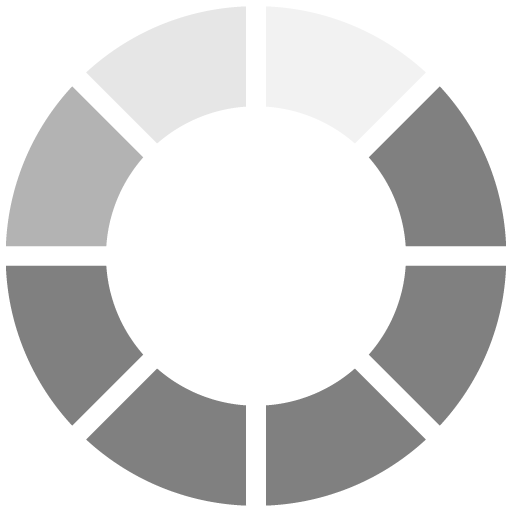Per riuscire, o perlomeno provare, a parlare di Haiti, di ciò che per me ha rappresentato, devo risalire al mio primo anno di liceo, ad una delle prime lezioni di italiano, alla spiegazione che la mia professoressa mi diede di una figura retorica: l’ossimoro. E come allora rimasi affascinata dalla capacità che hanno due opposti di creare tanta bellezza, così ora, una volta tornata a casa, di nuovo preda della routine, non riesco fare a meno di meravigliarmi, di scandalizzarmi, di vedere i miei occhi risplendere di una luce nuova ogni volta in cui penso o parlo di Haiti.
Quel piccolo pezzo di mondo per me è un ossimoro vivente, un insieme di contraddizioni che al tempo stesso ti attraggono e ti respingono. Quella che ho percepito è una realtà estremamente egoista perchè impegnata a tenere insieme – spesso e volentieri anche letteralmente – le sue macerie e al contempo altruista, generosa ed accogliente in modo sconvolgente: non ti rifiuta mai un “bonjou”, neanche se gridato di sfuggita dal retro di un pick up o se sussurrato con dolcezza nel reparto per i bambini malnutriti curati all’ospedale NPH del St. Damien.
Ho sempre pensato di essere capace di mangiarmi il mondo con gli occhi e credevo che al ritorno da questo campus avrei voluto conservare gelosamente quest’esperienza per me, ma nulla di tutto questo è successo. E’ stata Haiti a mangiare me, a spingermi a rimettere piede qui in Italia e a non smettere di gridare, di raccontare, di sforzarmi di comunicare quella che è stata un’esperienza assoluta. Assoluta nel senso proprio del termine, sciolta da qualsiasi legame con la vita vissuta fino ad ora, sciolta da qualsiasi legame pensavo potesse avere con le parole usate per descriverla. Qualcosa nella meccanica del mio cuore si è inceppato. Quando poi, però, è ripartito, ha iniziato a battere in modo differente. E sono stati proprio i contrasti a ridargli vita, a farmi acquisire una consapevolezza che si è stesa come un velo su tutte le cose che mi circondano. Non ho bisogno di chiudere gli occhi per sentire, percepire, la stretta delle mille mani che hanno stretto le mie e che affollano i miei sogni. Ci sono quelle di una bambina di Cité Soleil, che si è aggrappata alla mia maglietta e ai miei braccialetti e con cui ho ballato in mezzo ai rifiuti e a case fatte di lamiere. Poi ci sono le mani di *Abens, del bimbo di 8 anni che ho deciso di adottare a distanza, che mi ha trascinato in una danza scatenata fin dalla mia prima sera a Kenscoff e che, in confronto a quella bambina, vive in un piccolo angolo di paradiso. Paradiso e inferno, vita e morte, amore e violenza, sofferenza e pura gioia… sarebbe facile gestire solo uno di questi opposti, ma ad Haiti esistono tutti insieme, sempre nello stesso momento, spesso anche nello stesso luogo.
Nella cappella dell’ospedale pediatrico, alle 7 di mattina, Padre Rick parla di vita di fronte alla morte, tra le mura di quello che pare essere uno dei pochi porti sicuri del paese. I primi raggi di sole illuminano i teli sotto a cui sono adagiati corpi senza vita e si riflettono negli occhi dei miei compagni, di quelle trenta e più persone con cui ho condiviso tanti silenzi, tante mute parole, a cui saprò di essere per sempre e in parte connessa, anche quando saremo sparsi in giro per il mondo e il tempo passato a giocare coi bimbi della baby house, a sbucciare platani e patate e ad essere sballottati su un camion nel traffico soffocante di Port au Prince sarà solo un ricordo dai contorni sfumati.
Haiti è ogni giorno uno schiaffo e una carezza, una carezza e uno schiaffo, uno dopo l’altro. È la morgue, è il vociare indistinto tra la polvere che ricopre ogni cosa, é il corpo freddo di un neonato che immagino di cullare dolcemente, il canto in creolo che risuona nei campi della Titanyen e che si impregna dell’odore dei sigari fumati dai ragazzi di Padre Rick, dei loro sogni disillusi di cui ci raccontano tra un viaggio e l’altro. È la signora incinta che si aggrappa alla tua maglietta per ricevere prima degli altri un pacco di pasta, è lo sguardo nero, intenso, vero, di ogni haitiano, anche del più piccolo dei bambini delle case NPH, che ti pone mille e più domande a cui non sai dare una risposta. Ogni sguardo è una porta che si spalanca sul mondo e su te stesso.
Ringrazio la Fondazione Francesca Rava – NPH, i meravigliosi esseri umani di qualsiasi età e provenienza che mi hanno accompagnato e mi hanno aiutato a districarmi in quel groviglio di mani, di abbracci, di lacrime amare, di sorrisi e soprattutto di amore che è stata per me Haiti. E se siete arrivati a leggere fino a questo punto, non posso fare altro che dirvi di prendere un bagaglio e partire, e vedrete che tornerete con una valigia pesante, più pesante di quella con cui avevate lasciato la vostra casa e le vostre certezze. Partite e non abbiate paura di perdere e ritrovare la fede nell’uomo e nell’umanità un secondo dopo l’altro, di guardare le vostre mani e di non sentirle più vostre, di far fatica a riconoscervi davanti allo specchio, talmente tante saranno le mani che avrete stretto, talmente tante saranno le vite che vi saranno entrate nel cuore mescolandosi alla vostra. Tutto questo è successo anche a me e darei qualsiasi cosa per fare a meno delle parole e prendere per mano chiunque mi chieda di Haiti e portarlo lì, per vedere, perché ognuno la vede con occhi diversi. I miei amici scherzano, dicendo che sono tornata senza treccine nei capelli, che non è cambiato nulla nel mio modo di vestire e che non ho nemmeno imparato la lingua locale. Ma tutto quello che avviene ad Haiti non si ferma in superficie, non ti sfiora semplicemente, ti entra dentro e assume forme sempre nuove che ti accompagnano passo dopo passo, giorno dopo giorno.
Mèsi Haiti, wè ou talè. Grazie Haiti, ci vediamo presto.
Giulia
- Giulia, Campus in Haiti